Penny Wirton: la scuola senza classi che insegna l’italiano ai migranti
Eraldo Affinati è scrittore, saggista, insegnante di lettere, educatore. Nel 2008, con la moglie Anna Luce Lenzi, ha fondato a Roma la prima Scuola Penny Wirton per l’insegnamento gratuito dell’italiano ai migranti. Oggi la Penny Wirton conta 65 sedi in tutta Italia.
È autore di numerosissime opere, alcune citate nell’intervista, che hanno ottenuto molti e importanti riconoscimenti. Il suo ultimo libro, Testa, cuore e mani – Grandi educatori a Roma (il titolo riprende un’osservazione di Papa Francesco sulle caratteristiche di un educatore) è uscito il 12 maggio.
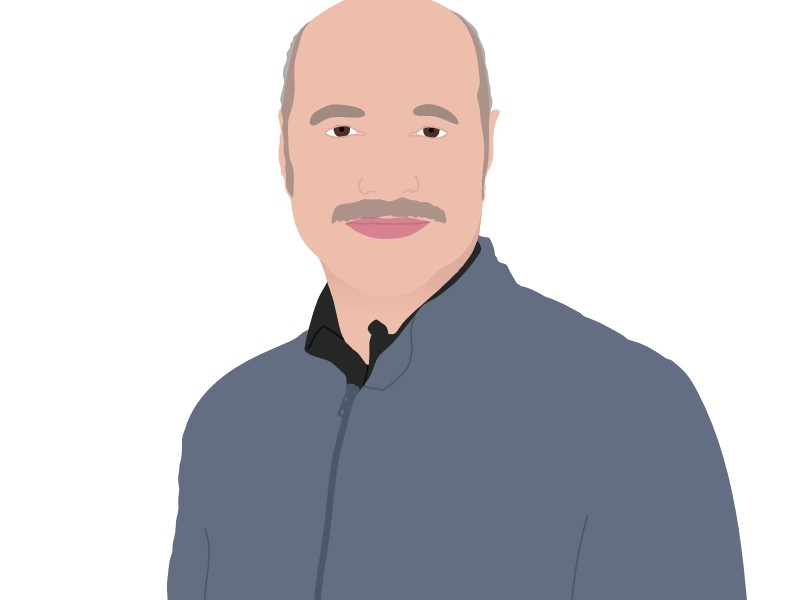
Come è venuta l’idea della scuola Penny Wirton?
«Sono sempre stato insegnante di lettere in istituti professionali, a contatto anche con ragazzi difficili. Molti dei miei studenti, quando sono andato a insegnare alla Città dei Ragazzi – una comunità educativa alle porte di Roma – erano immigrati provenienti da diversi Paesi, non italiani, e io dovevo insegnar loro l’italiano, cosa non facile. Però mi sono appassionato, mi sono interessato alle loro storie e ho compiuto dei viaggi in alcuni di quei Paesi, come Marocco, Gambia, Albania, sollecitato dagli stessi studenti, e ho scritto dei libri su queste esperienze molto forti.
La città dei ragazzi (Mondadori, 2008) è sul viaggio in Marocco, Vita di vita (Mondadori, 2014) su quello in Gambia; in questi viaggi ho cercato di capire e raccontare le ragioni profonde di questi ragazzi che vengono in Italia. Una volta tornato a Roma, con mia moglie Anna Luce Lenzi, anche lei professoressa, ci siamo chiesti cosa potessimo fare per questi ragazzi al di fuori di una scuola istituzionale, e così abbiamo deciso di fondarne una di tipo nuovo, chiamandola Penny Wirton».
A cosa si deve il nome?
«Penny Wirton è un personaggio creato dallo scrittore Silvio D’Arzo (sulla cui opera mi ero laureato, così come mia moglie, incontrata proprio grazie a questa coincidenza). È un bambino che non ha mai conosciuto il padre, un orfano, e i nostri studenti sono spesso minori non accompagnati».
Come è organizzata la scuola?
«La prima intuizione è stata quella di non avere classi: in una scuola tradizionale c’è il professore che spiega a un gruppo di alunni, mentre da noi il rapporto è uno a uno, e le cose cambiano del tutto. Si instaura un rapporto di amicizia, di empatia, che deve scattare tra chi insegna e chi apprende. Naturalmente, però, in questo modo abbiamo avuto bisogno di tantissimi volontari, essendo tra l’altro una scuola completamente gratuita, senza soldi né finanziamenti. Abbiamo voluto puntare tutto sulla motivazione profonda dei volontari. All’inizio era sembrata un po’ una follia, un sogno, ma nel tempo è piaciuta molto, e ci sono associazioni che già operavano sul territorio, non solo a Roma ma in tutta Italia, che hanno deciso di affiliarsi a noi, perché il nostro stile educativo è piaciuto. Sul nostro metodo abbiamo pubblicato un libro, Italiani anche noi (Erickson, 2019), e oggi abbiamo 65 scuole in Italia e migliaia di persone coinvolte. Ci mettiamo tutto il cuore, perché non è solo un fatto didattico, ma di umanità. Nelle nostre scuole devi andare a conoscere chi hai davanti, perché ognuno è diverso: ad esempio, puoi avere l’analfabeta nella propria lingua madre o quello già laureato, non puoi basarti solo su un programma del tipo “insegniamo l’italiano”».
In che modo sono coinvolti i ragazzi italiani?
«Utilizziamo i PCTO, cioè le ore di tirocinio formativo che gli studenti delle superiori italiane sono tenuti a fare, con protocolli d’intesa con licei di diverse città: in tal modo formiamo gli adolescenti italiani come docenti dei loro coetanei immigrati. Metterli in contatto tra loro è uno degli aspetti più belli delle scuole Penny Wirton. È interessante notare come molti di questi giovani italiani non siano tra quelli che vanno tanto bene a scuola: a volte sono stati bocciati o sono un po’ indisciplinati, invece da noi realizzano qualcosa che in classe tengono nascosto, si identificano facilmente con i ragazzi stranieri appena arrivati. Questo dice molto anche sulla scuola italiana, che dovrebbe essere un po’ rivista: a tal proposito ho scritto un libro, Elogio del ripetente (Mondadori, 2013)».
Come vengono scelti gli insegnanti volontari?
«Quando qualcuno viene da noi proponendosi come volontario, ovviamente gli parliamo, spieghiamo cos’è la Penny Wirton, il nostro stile, facciamo una sorta di formazione, e lo affianchiamo a una coppia insegnante/allievo già attiva, poi pian piano si inserisce e può diventare autonomo. Dovrei in realtà usare il femminile, dato che circa il 70% delle persone volontarie sono donne. Completando il discorso, non c’è bisogno di una vera e propria selezione, dato che chi viene da noi ha già una forte spinta motivazionale, e conta molto l’empatia che riesce a creare, la capacità di interagire con la persona che ha di fronte, non tanto la cultura accademica. Inoltre, ogni volontario o volontaria ha una sua motivazione, che può essere politica, religiosa, esistenziale. In alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i pensionati, e ne abbiamo tanti perché hanno del tempo da dedicare, può essere legata a un momento di depressione, qui superata perché trovano una vitalità nuova, si sentono e si rendono utili e conoscono tante persone».
C’è qualcosa di Penny Wirton in lei, e che l’ha spinta verso la sua attività?
«Sono figlio di due orfani. Mio padre fu abbandonato dal proprio, che non si sa chi fosse, e infatti il cognome Affinati è quello della nonna. Durante il fascismo e la guerra mio nonno materno era partigiano e fu fucilato dai nazisti. Mia mamma, in quanto sua figlia, fu deportata nel 1944 ma riuscì a fuggire dal treno alla stazione di Udine. Però non è riuscita a elaborare fino in fondo la sua storia, perché non aveva studiato: entrambi i miei genitori avevano solo la quinta elementare. Quando chiedevo a mio padre come avesse fatto a cavarsela da solo a Roma, o alla mamma come fosse riuscita a scappare, loro non erano in grado di soddisfare la mia curiosità, perché non avevano le parole. Per questo oggi, insegnando e scrivendo, è un po’ come se volessi risarcire i miei genitori di quello che loro non ebbero la fortuna di avere. È una motivazione molto profonda, necessaria per capire la mia predisposizione pedagogica e letteraria. Non a caso ho scritto due libri su Don Lorenzo Milani, perché in fondo sono stato un “ragazzo di Barbiana”: diventato insegnante, mi sono sentito portato verso i ragazzi fragili, difficili, proprio perché anch’io ero stato così».
– Eraldo Affinati
“Metterli in contatto tra loro è uno degli aspetti più belli delle scuole Penny Wirton. È interessante notare come molti di questi giovani italiani non siano tra quelli che vanno tanto bene a scuola: a volte sono stati bocciati o sono un po’ indisciplinati, invece da noi realizzano qualcosa che in classe tengono nascosto, si identificano facilmente con i ragazzi stranieri appena arrivati. Questo dice molto anche sulla scuola italiana, che dovrebbe essere un po’ rivista“

