Intervista allo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, Presidente della Fondazione Minotauro
Matteo Lancini è uno psicologo e psicoterapeuta e Presidente della Fondazione Minotauro di Milano, un Centro clinico di consultazione e psicoterapia e una Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per l’adolescente e il giovane adulto.
Tra i più autorevoli esperti di adolescenza e relazioni educative in Italia, al Bullone racconta il complicato rapporto tra fragilità e futuro.
In questa edizione del nostro mensile, ci siamo confrontati con le nostre aspirazioni e i nostri desideri, ma una domanda sorge spontanea: i giovani credono ancora nel futuro?
«Adesso la vicenda è complicata dal fatto che questo tema del futuro è aggravato sia dai comportamenti degli adulti – che hanno disboscato il pianeta, plastificato i mari e li hanno resi più poveri – sia dal modo in cui gli adulti non solo non si preoccupano di preservare la Terra, ma faticano enormemente a costruire strumenti adeguati per le nuove generazioni. Penso, ad esempio, alla scuola o al modo di crescere i ragazzi in questa complessità: spesso non sono adatti a loro. Quindi non è che tutti i ragazzi abbiano perso speranza nel futuro. Gli adulti, con le loro scelte degli ultimi anni non li stanno certo aiutando o rassicurando sul fatto che un futuro ci sarà per loro. Basta pensare alle guerre, al pianeta, o a una scuola che, invece di essere organizzata per i ragazzi, è strutturata sulle ansie degli adulti e serve soprattutto a far sentire adatti gli adulti stessi».
In un’intervista lei ha raccontato: «Il vero tema è come mai questi adolescenti si sentono così soli in mezzo agli adulti. (…) Io credo che anche a scuola i ragazzi dovrebbero avere il cellulare sempre acceso e fare le lezioni con questo strumento». Ma i giovani, tra di loro, come si sentono? Le loro identità digitali come coesistono con le loro identità reali?
«Sono la stessa cosa. Oggi non c’è più distinzione. Chi non si accorge che ogni giorno vive ogni ruolo, ogni identità e ogni azione lavorativa in integrazione tra la vita reale e la vita virtuale, semplicemente non vede ciò che accade.
Gli adulti vivono ogni giorno in questa società “online”, ma spesso non se ne accorgono. Dire a un ragazzo di 17 anni che deve lasciare il telefono fuori dall’aula per dimostrare di essere un bravo insegnante non ha senso: tutto il mondo vive online. Esistono insegnanti che sono diventati tra i più importanti influencer in Italia, guadagnano, vendono libri, raccontano pubblicamente la propria vita e identità, e fin qui va tutto bene. Poi però non dovrebbero permettersi di andare in televisione o in radio a sostenere che bisogna vietare i social e lo smartphone ai ragazzi e alle ragazze.
Questa è la testimonianza di adulti che vogliono tutto, ma non si identificano con i bisogni delle nuove generazioni, dei bisogni attuali e futuri dei loro studenti, si tratta di una dissociazione. E il livello è ancora più grave se si pensa che mentre i giovani sono esposti ogni giorno a guerre, morti, bambini feriti, immagini di distruzione, si sostiene che la violenza giovanile dipenda dai videogiochi. Internet non è un vizio: è la vita, è l’identità delle nuove generazioni. Basta guardare a chi governa il mondo, a come si muovono i genitori, al fatto che oggi conta essere in qualsiasi campo un influencer. La scuola vieta il cellulare, ma poi usa WhatsApp per i compiti e il registro elettronico».
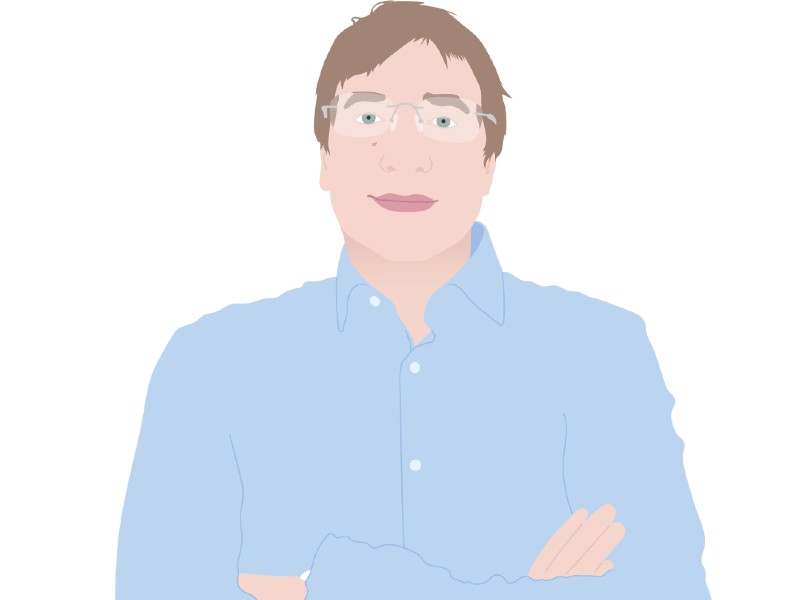
Minotauro di Milano. Insegna presso il dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. È autore di diversi libri.
Illustrato da Chiara Bosna.
In Italia oggi si vive soli sempre più spesso. Ma dunque, quando si smette di essere adolescenti e si inizia ad essere adulti? Quando, anche la Generazione Z, potrà avere un suo posto al «tavolo dei grandi»?
«Non so quando gli adolescenti o i giovani si siederanno al tavolo degli adulti, bisognerebbe chiederlo agli stessi ragazzi. Se aspettano che gli adulti lascino loro uno spazio, sarà difficile. Agli adulti non piace invecchiare: molte istituzioni in Italia sono governate da persone che si sostituiscono l’un l’altra senza grande ricambio generazionale. Questo lascia poco spazio ai giovani.
Forse la domanda giusta è: perché le nuove generazioni non si riuniscono e non dicono chiaramente “guardate, noi non veniamo più a scuola finché non ce ne fate una per noi e non per voi”? Immaginate se due milioni di ragazzi non andassero più a scuola: le istituzioni reagirebbero, perché le istituzioni cambiano quando non hanno più clienti.
Prendiamo un episodio recente: tre ragazzi che alla maturità hanno scelto di non rispondere alle domande perché stavano male — non perché volessero “scandalizzare”, ma perché la scuola li aveva feriti. Invece di capirli, molti adulti li hanno trattati come delinquenti. Come può un giovane esprimere dissenso se viene subito +criminalizzato?».
Ma allora quale può essere la soluzione?
«La soluzione non è vietare: è costruire una scuola pensata per loro, dove contino le loro domande, dove si possano svolgere prove aperte su internet e si usino gli strumenti digitali in modo coerente con la realtà esterna. Ci sono insegnanti e dirigenti che provano a cambiare, ma servirebbe una ristrutturazione profonda: ruolo docente, metodi di insegnamento, criteri di valutazione. Infine, voglio essere chiaro: io sono contrario a internet e ai social.
La mia non sarà mai una difesa di internet, ma è una critica alla dissociazione degli adulti, alla contraddizione tra l’uso che loro stessi fanno della rete e ciò che impongono ai giovani. Il punto è che gli adulti ascoltano molto, ma non stanno costruendo idee o istituzioni a sostegno dei giovani e del loro futuro. Così i ragazzi e le ragazze se ne vanno, o abbandonano la scuola per sopravvivere psicologicamente o emigrano all’estero. Questo è il vero problema da affrontare».
«Abbiamo paura di fallire, di sbagliare, il futuro ci spaventa, e allora non facciamo niente», raccontano i nostri ragazzi. È un sentimento diffuso? E come possiamo aiutarli, stabilendo una nuova relazione con la paura e il fallimento?
«Se parliamo del fallimento tra i giovani, bisogna prima chiarire che il problema non risiede solo nella loro paura del futuro o nel fatto che non siano abituati alle frustrazioni, come si tende a raccontare. Oggi i giovani e i giovanissimi se esprimono i propri pensieri o le proprie emozioni rischiano di essere percepiti come “falliti” dagli adulti. Questo accade perché ogni loro scelta o emozione che non si allinei alle aspettative di genitori, insegnanti o educatori viene giudicata sbagliata. Di conseguenza, cresce in loro una paura profonda di mostrarsi autentici e di seguire i propri desideri, perché sanno che questo li esporrebbe a critiche e disapprovazione. Stiamo parlando di adolescenti che si trovano ancora in una forte dipendenza economica e affettiva dai genitori. Frequentano una scuola che spesso premia l’adattamento e la ripetizione delle informazioni, piuttosto che la creatività o l’autenticità.
La scuola alimenta la competizione e la usa come forma di potere e valutazione numerica, non è un ambiente che favorisce l’apprendimento ma promuove la raccolta di voti. In questo contesto, è comprensibile che molti ragazzi sperimentino ansia e paura del fallimento. Finché gli adulti ti tratteranno come falliti quando sono loro stessi, avranno paura di fare qualsiasi cosa. L’altra opzione è ammalarsi, impazzire, diventare come vogliono gli altri.
Dobbiamo cambiare il modo in cui osserviamo e supportiamo i giovani: non come individui da controllare o misurare numericamente, ma come persone da guidare, valorizzare e ascoltare».
E infine, lei, che rapporto ha con il suo futuro?
«Quello che ho imparato nella vita è che bisogna avere sempre un progetto. Per questo motivo, al momento investo in quelli che considero progetti significativi, è un modo per dare senso alla vita. Siamo immersi in una società che ha continuato a raccontare ai ragazzi di aver dato loro tutto, ma che ha rimosso il dolore. Il rapporto con il futuro dovrebbe includere la capacità di tollerare tristezza, dolore e paura, che fanno parte dell’essere umano. Nemmeno durante la pandemia abbiamo parlato della morte a scuola o con i figli a tavola. Quando i ragazzi tornavano a scuola non c’era spazio per affrontare emozioni profonde. Negli ultimi anni, adolescenti e giovani adulti hanno assunto un senso di disperazione e profondità emotiva enorme. Si ignora il fatto che il problema riguarda la difficoltà dell’adulto di comprendere e supportare i giovani. Ogni giorno il comportamento di genitori, insegnanti e politici ha un impatto enorme, ma spesso non viene considerato».
– Matteo Lancini
“La soluzione non è vietare: è costruire una scuola pensata per loro, dove contino le loro domande, dove si possano svolgere prove aperte su internet e si usino gli strumenti digitali in modo coerente con la realtà esterna. Ci sono insegnanti e dirigenti che provano a cambiare, ma servirebbe una ristrutturazione profonda: ruolo docente, metodi di insegnamento, criteri di valutazione.“

